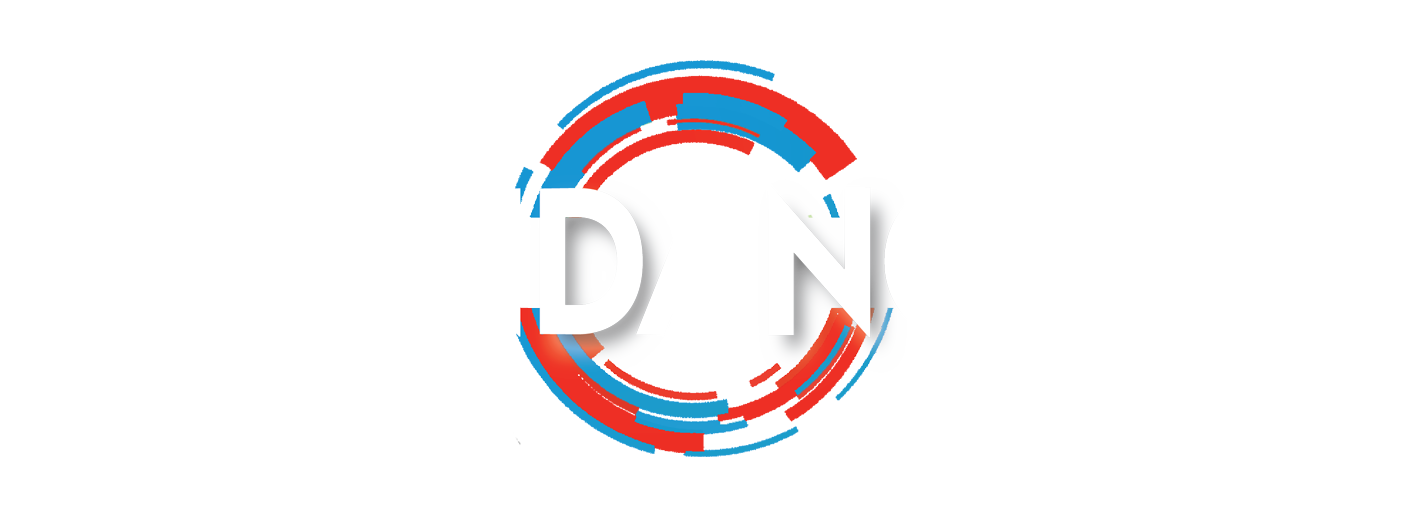Domani, Giornata nazionale della memoria e dell’accoglienza, ricorre il nono anniversario del tragico naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nel 2013 e che provocò la morte di 368 persone, tra cui 83 donne e 9 bambini.
Da quel tragico incidente ad oggi, quasi 25.000 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo, quasi 20.000 dei quali lungo la rotta del Mediterraneo centrale.
Solo nel 2022, sono già 1.400 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Di queste, l’84% sulla rotta del Mediterraneo centrale che si conferma come una delle più attive e pericolose a livello globale.
Lo rendono noto l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr), e il Fondo delle Nazioni unite per l’Infanzia (Unicef), che sono presenti oggi a Lampedusa con il Comitato 3 Ottobre, le organizzazioni della società civile, i rappresentanti delle istituzioni governative locali, nazionali ed europee per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nel tentativo disperato di trovare sicurezza e protezione in Europa.
Le organizzazioni hanno inoltre aderito alle attività organizzate dal Comitato 3 Ottobre nell’ambito del progetto Welcome Europe, con l’obiettivo di promuovere nelle giovani generazioni italiane ed europee una cultura di solidarietà, accoglienza e dialogo, fondata sul rispetto dei diritti umani e dell’imperativo umanitario e giuridico di salvare vite in mare.
E l’Agenzia Ansa rievoca attraverso un reportage la tragedia con le testimonianze dei superttiti:
Randa, Sherihan, Nurhan, Christina. Tatuati sull’avambraccio sinistro, con dei cuoricini all’inizio e alla fine, ha i nomi delle figlie, di 10, 8, 5 e mezzo e quasi 2 anni. Bambine i cui corpi, dopo il naufragio dell’11 ottobre 2013, non sono stati mai trovati.
Ha lo sguardo fisso sull’ingresso dell’istituto Pirandello di Lampedusa – dove è un via vai di studenti europei e dove è stata portata la testimonianza dei sopravvissuti dei naufragi del 3 e 11 ottobre di 9 anni fa e dei familiari delle vittime – e non apre bocca, quasi fosse ancora sotto choc.
“Ogni istante di quel viaggio è scolpito nella nostra memoria, per due anni ci siamo svegliati ogni notte chiamando il nome delle nostre figlie che sono disperse – ha raccontato il marito: Wahid Yussed, siriano sessantunenne, già direttore del reparto di Pneumologia in un ospedale della Libia -. La situazione è un po’ migliorata grazie a Dio che ci ha donato altre due figlie, ma abbiamo avuto bisogno di grande supporto psicologico perchè pensavamo che la vita fosse finita dopo quel giorno”.
La coppia vive a Dussemburg in Germania dove il medico studia il tedesco e spera di poter tornare in reparto. Dopo il naufragio sono stati, per 7 anni, come rifugiati politici, in Svizzera. Da 2 anni sono invece in Germania. “Mi sento in colpa. Perchè io sono sopravvissuto e loro, le mie bambine, no. Perchè?” – continua a chiedersi il medico siriano che, per la prima volta, dopo la tragedia, è tornato a Lampedusa e sarà presente anche domattina alla marcia della “Giornata della memoria e dell’accoglienza” che da piazza Castello arriverà fino a Porta d’Europa.
A raccontare la sua storia agli studenti anche Solom, eritreo, di 32 anni, sopravvissuto del naufragio del 3 ottobre, che da qualche tempo vive in Svezia: “Ogni anno torno a Lampedusa e vado anche al cimitero di Agrigento a portare dei fiori ai miei amici. Ero partito con loro, avevano tutti 22 e 23 anni. Sono l’unico che si è salvato”. Solom, in Svezia, fa l’autista di camion, si è sposato con una connazionale e ha un bambino di un anno e due mesi.
“Devo la mia vita a Vito Fiorino, ‘My father’, è lui che mi ha salvato – spiega -. Sono scappato dal mio Paese, l’Eritrea, e, con i miei amici, ho attraversato l’Etiopia, il Sudan, il deserto del Sahara fino in Libia. Siamo stati rapiti e mi hanno chiesto 5 mila dollari per essere liberato. Grazie a Dio, mio fratello ha pagato il riscatto e sono partito dalla Libia. In Svezia, all’inizio, è stato difficile, ma poi ho capito il sistema e se ti impegni e trovi un lavoro, la vita è molto bella”.
Solom chiede a tutti gli africani in fuga dal paese di origine di non prendere i barconi e di provare ad arrivare in maniera legale: “Vivere in patria è difficile, si può morire. Ma si può morire anche sui barconi. Dopo quello che ho vissuto chiedo a tutti di non dare soldi per il viaggio con i barconi, andate in Sudan o in Etiopia e attendete che la situazione migliori”.
A Lampedusa c’è anche Fanus, aveva 16 anni il 3 ottobre del 2013 ed è stata l’unica a riconoscere lo scafista e a denunciarlo. E’ rimasta 3 mesi, allora, all’interno dell’hotspot. Ancora adesso si chiede come ha fatto a sopravvivere al naufragio, visto che non sa nuotare. Adesso vive in Svezia e ha 3 figli.
E poi c’è Adal: è stato il primo, il 3 ottobre del 2013, ad arrivare, da naufrago, a Lampedusa e a ricostruire tutti i nomi delle vittime. Ha perso suo fratello nella tragedia che determinò 368 vittime. Ma anche Abel che è ancora minorenne ed è timidissimo. Nel naufragio ha perso il padre e non riesce, ancora oggi, a superare il trauma. Gli studenti hanno ascoltato anche le testimonianze dei lampedusani che, in quella notte d’inferno, si mobilitarono.
“Ho ancora davanti agli occhi quello scenario terrificante, almeno 200 persone che mi guardavano, urlavano e volevano essere aiutate – ha raccontato Vito Fiorino – . Ho pensato 4 o 5 li devo salvare. Ho iniziato a portare a bordo questi ragazzi, arrivavano nudi, erano sporchi di petrolio e mi scivolavano dalle mani. Mi dissero che erano circa 500 su quella barca e che verso mezzanotte, una grossa imbarcazione si era avvicinata, li aveva illuminati e se ne era andata. Per indifferenza quella notte, 368 persone, sono morte. Fra i giovani che ho soccorso con la ‘Gamar’ (il nome della barca di Fiorino, ndr) ce n’era uno completamente nudo che appena è stato issato a bordo mi ha chiesto dei pantaloni. Quel ragazzo era Solom che, quella notte mi ha insegnato la mia prima parola di inglese: ‘My father'”.
A parlare anche Costantino Baratta, il pescatore che salvò13 ragazzi: “Il mare, davanti alla barca, era pieno di cesti di capelli e di occhi fuori dalle orbite. Tutti urlavano: ‘Help me, help me’. Casa mia, nei mesi successivi, si è trasformata in un internet-point perche’ tutti i ragazzi soccorsi facevano avanti e indietro per usare il pc e provare a rintracciare i propri familiari. Uno dei ‘miei’ ragazzi solo dopo 2 anni è riuscito a mettersi in contatto con il fratello in Inghilterra. Adesso, con tutti loro, siamo sempre in contatto. Siamo una famiglia allargata, una famiglia internazionale”.